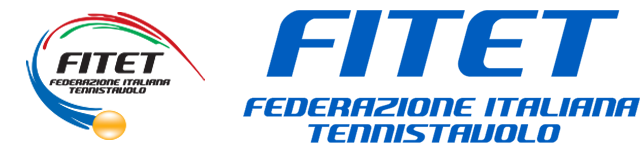Campus estivo Progetto Giovani FITeT day 3
- Pubblicato: 14 Agosto 2012
 Prosegue a Terni l'impegnativo programma del Campus Progetto Giovani.
Prosegue a Terni l'impegnativo programma del Campus Progetto Giovani.In mattinata quarta seduta a chiusura del primo dei tre cicli di attività: si completa quindi il percorso di apprendimento facilitato da speciali situazioni motorie e di tennistavolo.
I tecnici federali quotidianamente si confrontano, analizzano le immagini, per “cercare le strade” più efficaci al fine di incrementare le opportunità di acquistare i riferimenti più semplici per l’apprendimento delle abilità.
Strategia assai diversa da quella che viene utilizzata quando ci si occupa di allenamento: presuppone infatti l’identificazione di obiettivi di attività non necessariamente indirizzati al prodotto ma al processo.
Infatti il traguardo da raggiungere non è definibile soltanto come la ripetizione di un compito preciso in una situazione definita (proprio dell’allenamento sportivo, in cui si cerca un risultato attraverso una prestazione).
Risiede invece nella capacità di riconoscere e selezionare gli stimoli (visivi, uditivi, propriocettivi, tattili, in particolare), produrre delle risposte motorie adeguate (ma non necessariamente stereotipate), risolvere dei problemi motorie e cognitivi.
Promuove quindi un lavorio mentale assai significativo.
I tecnici quindi debbono creare una sorta di “difficoltà”, promuovendo esercitazioni che richiedano il riconoscimento della velocità, della rotazione, del piazzamento e profondità della pallina, del tempo di impatto.
Debbono, parallelamente, far “sentire” le parti del corpo che si muovono nello spazio e per “un tempo”.
Per esempio se la mobilità, lo spostamento del corpo, rappresentano un requisito indispensabile per produrre azioni precise durante la pratica del tennistavolo, diviene indispensabile, prima di allenare “i passi” (obiettivo di prodotto), conoscere, riconoscere e riprodurre:
· l’appoggio e la spinta dei piedi, per avanti-dietro-laterale;
· la gestione della distribuzione del peso corporeo in differenti situazioni (su un unico piede, su entrambi i piedi, nella stazione eretta, con il busto inclinato avanti);
· il movimento della parte superiore del corpo in relazione alle caratteristiche della base di appoggio in funzione al mantenere oppure perdere l’equilibrio;
· l’azione di rotazione del corpo (spalle, anche, piedi in particolare) per produrre azioni sulla pallina che abbiano una direzione dietro-avanti.
Questi obiettivi di sollecitazione dei processi motori e cognitivi debbono essere perseguiti utilizzando il continuo abbinamento di esercitazioni motorie e specifiche.
Queste scelte risiedono nelle più recenti evidenze della Letteratura internazionale dalle quali si evince che le persone (soprattutto le più giovani) imparano integrando sensazioni, esperienze, conoscenze, emozioni: ciò avviene non solo imitando comportamenti altrui ma anche e soprattutto percependo, sentendo, il proprio movimento, comprendendo i riferimenti spazio temporali e quali siano le esigenze del compito da eseguire.
Altra esigenza di questa strategia per l’apprendimento richiede di determinare quale situazione possa generare gli effetti attesi, cioè il comportamento del giovane praticante.
Se l’esercitazione produce effetti non coerenti con l’obiettivo, non si può considerare raggiunto lo scopo prefissato, anche se il tecnico interviene con contributi, feedback verbali.
Per esempio, nel caso di esercitazioni al tavolo, laddove la situazione prevista (o la sua realizzazione) produca una pallina con una traiettoria alta, poco profonda magari anche lenta, il giovane “perde” la posizione di gioco, si “rialza”, non riesce a mantenere una corretta e continua dinamica.
Un evenienza di questo tipo produce una serie di negativi effetti a catena: il giovane infatti comincia a riprodurre soltanto una parte della complessa catena cinetica che dovrebbe prevedere l’intervento
· dei piedi (in avvicinamento alla direzione ed alla profondità della pallina che arriva; in appoggio, rotazione, spinta per l’azione da realizzare),
· delle gambe e delle anche (che consentono l’allineamento della parte superiore del corpo rispetto alla direzione di impatto della pallina e “trasferiscono”la spinta al busto),
· delle spalle, del braccio, dell’ avambraccio e delle mano (che realizzano il cosiddetto “colpo di frusta, cioè completano l’azione che si traduce in una accelerazione più o meno importante della racchetta sulla pallina).
E laddove venga meno l’attenzione rispetto a questi fattori, l’atleta viene indotto a produrre movimenti degli arti superiori “lunghi”, aumenta il disequilibrio rispetto alla base di appoggio, si alza e …. si ferma!
Avere a cuore l’apprendimento, spinge il tecnico a “riconoscere” i limiti cognitivi, coordinativi e di favorire una padronanza motoria che è prerequisito per lo sviluppo della rapidità anche nelle più complesse situazioni specifiche di pratica durante il match.